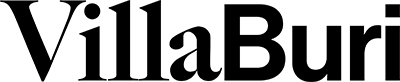La presenza di persone richiedenti asilo in Italia è un fenomeno complesso, caratterizzato da un intreccio di normative, sfide pratiche e percorsi di inclusione che meritano un’analisi approfondita.
Protezione e Diritti: Un Quadro Normativo in Evoluzione
Innanzitutto bisogna sapere che la migrazione in Italia è regolata da un quadro giuridico che include livelli internazionali e nazionali. Nel nostro caso, la Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 10, stabilisce che la persona straniera cui sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. In Italia, attualmente, i riconoscimenti che si possono ottenere sono la protezione internazionale e la protezione speciale.
All’interno della protezione internazionale, è possibile ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, dello status di rifugiatə. L3 titolari di protezione sussidiaria sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato). Le persone rifugiate sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine. La protezione internazionale garantisce innanzitutto il diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia. Nel caso eccezionale in cui non si possa riconoscere la protezione internazionale, ma nel Paese di origine la persona è comunque a rischio di persecuzione, tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, può esserti riconosciuta la protezione speciale.
Le protezioni vengono vengono assegnate a seguito di un colloquio in Commissione Territoriale, organo deputato a decidere. Il giorno del colloquio l’intervistatorə aiuta le persone a ricostruire la propria storia e le informazioni richieste riguardano: l’identità (origini, famiglia, cultura, studi, lavoro ed eventualmente la religione, le idee politiche ); i motivi per cui si è deciso di lasciare il proprio Paese di origine; i timori che si hanno a tornare nel proprio Paese di origine ed i rischi in cui si incorerebbe.
Tuttavia, queste protezioni non garantiscono tutte gli stessi diritti:
Durata del permesso: Per la protezione internazionale permesso di soggiorno ha una validità di 5 anni, rinnovabile; per viaggiare fuori dall’Italia puoi richiedere un documento di viaggio (se sei rifugiatə) o titolo di viaggio (se sei titolare di protezione sussidiaria e vi sono fondate ragioni per cui tu non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del tuo Paese). Per la protezione speciale, invece, permesso di soggiorno ha la validità di 2 anni, rinnovabile solo nel caso in cui continui ad aver bisogno di protezione. Si può chiedere un titolo di viaggio per stranieri, se non si può ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del proprio Paese di origine.
Lavoro: Se sei beneficiariə di protezione internazionale, puoi accedere al mercato del lavoro, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni de3 cittadin3 dell’Unione Europea. Nel caso di protezione speciale, puoi lavorare regolarmente, ma non puoi convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Assistenza sanitaria: Per quanto riguarda l’accesso ai servizi, la legge prevede l’iscrizione al servizio sanitario Tuttavia, alcune regioni non riconoscono pienamente i diritti sanciti dalla legge, come la tutela del minore o l’esenzione dal ticket sanitario.
Cittadinanza: L’acquisizione della cittadinanza per le persone beneficiarie di protezione internazionale segue in generale la disciplina prevista per le altre persone straniere, con una rilevante eccezione: chi ha lo status di rifugiato è equiparato all’apolide e può chiedere la naturalizzazione dopo soli cinque anni di residenza legale. Questo non è invece previsto per la protezione speciale.
Le Sfide dell’Inclusione e il Sistema di Accoglienza
Nonostante le normative, l’inclusione presenta diverse criticità. Avere una residenza stabile e continuativa è connesso alla stabilità economica e lavorativa; e la questione degli spazi abitativi per ospitare i familiari ricongiunti rappresenta una delle maggiori difficoltà pratiche.
Ottenere un contratto di lavoro regolare e a lungo termine è una sfida difficile per le persone rifugiate, che spesso provengono da contesti di vulnerabilità. Inoltre dopo l’uscita dalle strutture di accoglienza, la loro condizione di debolezza può tradursi in povertà ed emarginazione, innescando meccanismi a spirale.
Un’indagine del 2020 ha evidenziato che il 43,9% delle persone intervistate ha valutato come insufficienti i sistemi di accesso alla salute (fisica e mentale) per le persone richiedenti asilo e beneficiarie di protezione internazionale, mentre quasi metà ha ritenuto sufficiente l’accesso alla scuola per bambini e bambine. Il sistema di accoglienza italiano per le persone migranti è stato spesso descritto con opinioni negative, utilizzando espressioni come “lungo e poco orientato alla promozione dell’autonomia”, “emergenziale”, “inadeguato”, “assistenziale”.
Negli ultimi anni però, l’Italia è diventata sempre più un Paese di destinazione anziché solo di transito per molte persone migranti che chiedono protezione, con una marcata tendenza a restare nel nostro Paese, rendendo ancora più urgenti gli interventi per affrontare le criticità dell’accoglienza e promuovere l’inclusione.
La Vulnerabilità Psicologica e la Salute Mentale
Un aspetto cruciale, ampiamente dibattuto all’interno del Sistema di protezione, è il tema della fragilità psicologica delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale. Spesso le persone migranti arrivano in buona salute ma si ammalano a causa delle condizioni di vita e accoglienza. Non dare la giusta considerazione al vissuto di queste persone, caratterizzato da sofferenze e traumi legati a conflitti, violenze subite durante il viaggio e incertezze e isolamento sociale nel Paese d’arrivo, possono portare a episodi di disadattamento o aggressività e rendere i disturbi molto più gravi e cronici, con un costo maggiore.
La presa in carico di persone con fragilità psicologiche all’interno del sistema di protezione e nei centri governativi richiede una rete capace di attivarsi in emergenza e garantire continuità operativa. È fondamentale considerare la vulnerabilità non solo come condizione individuale di partenza, ma anche come prodotto dell’interazione tra l’individuo e il contesto sociale. L’accoglienza deve essere sensibile alle esperienze traumatiche, sia quelle passate nel Paese d’origine o durante il viaggio, sia quelle legate all’incertezza nel Paese d’arrivo, inclusa la “violenza” prodotta dalle istituzioni e dai protocolli, come le difficoltà nell’accesso ai servizi o la percezione di indifferenza. Un approccio di cura deve integrare passato e presente, restituendo al paziente un senso di durata.
L’accoglienza a Villa Buri
Dalle parole di un’intervista fatta da alcun3 student3 dell’E-inauDigital Agency a Mercy e Adeshola, due donne accolte insieme aifigl3 a Villa Buri, emerge un quadro positivo dell’accoglienza ricevuta. L’ambiente viene descritto con calore, con dolcezza, quasi come una famiglia: “Qui siamo tutti come una famiglia”. Viene sottolineata inoltre l’importanza della comunicazione e del supporto emotivo che ricevono, poiché a Villa Buri “Loro sempre vogliono che noi condividiamo i nostri problemi” e “Dobbiamo condividere i nostri dolori, se non siamo felici”. Il luogo è percepito come “diverso da altri posti”, un luogo di libertà dove “siamo liberi” e “siamo tutti amici”. Questa libertà si estende anche a bambin3: “I miei figli possono giocare e, anche se sono molti, sono liberi di fare ciò che vogliono, a differenza di altri luoghi dove non si può fare rumore”. Per questi motivi, Villa Buri viene definita “il migliore posto in Europa” o semplicemente“il migliore”. L’esperienza a Villa Buri si distingue quindi per il suo senso di comunità e libertà.
Fonti
“Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio” su temi.camera.it
“Accoglienza ed inclusione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia. Sfide e dinamiche evolutive” su euricse.eu
“20 giugno – Giornata Mondiale del Rifugiato: il ruolo chiave dell’UNHCR” su unhcr.org
“Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia” Italiahttps://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-09/guida_pratica_2024_italiano.pdf